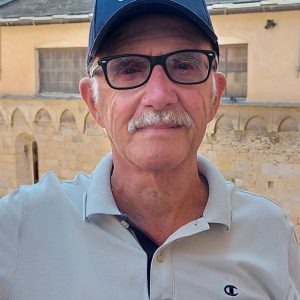Qualcuno si sarà stupito del risultato delle elezioni a New York: dopo un anno dalla rivincita di Donald Trump, col Partito Democratico che non si è ancora riavuto dalla batosta subita e sembra del tutto incapace di contrastare le politiche del tycoon, nella Grande Mela trionfa – e di molte lunghezze – un candidato di fede islamica che si proclama orgogliosamente socialista. Con un programma che promette nuove tasse per i più abbienti, affitti e supermercati a prezzi calmierati, addirittura trasporti pubblici gratuiti.
di Massimo Ferrari
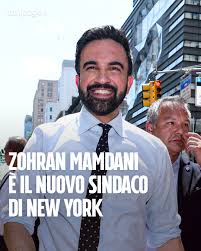 Vedremo cosa il nuovo sindaco riuscirà poi a realizzare. New York è la sola metropoli Usa in cui il treno costituisce una opzione di spostamento prioritaria, se non al livello dell’Estremo Oriente, almeno quanto siamo abituati a considerare in Europa. E che dire della Liguria, stretta in un fazzoletto di terra tra i monti e il mare, dove pure si insiste ad allontanare la ferrovia dai centri abitati, con il prevedibile risultato di scoraggiare l’uso del treno. E di accrescere l’intasamento viario. Se proprio vogliamo continuare ad inseguire il sogno americano, seguiamo allora l’esempio di New York.
Vedremo cosa il nuovo sindaco riuscirà poi a realizzare. New York è la sola metropoli Usa in cui il treno costituisce una opzione di spostamento prioritaria, se non al livello dell’Estremo Oriente, almeno quanto siamo abituati a considerare in Europa. E che dire della Liguria, stretta in un fazzoletto di terra tra i monti e il mare, dove pure si insiste ad allontanare la ferrovia dai centri abitati, con il prevedibile risultato di scoraggiare l’uso del treno. E di accrescere l’intasamento viario. Se proprio vogliamo continuare ad inseguire il sogno americano, seguiamo allora l’esempio di New York.
Tutto questo è avvenuto non tanto perché ci siano ora i presupposti per una vigorosa inversione di rotta nelle dinamiche elettorali a stelle e strisce, ma semplicemente perché New York – assieme ed in misura maggiore di poche altre città come Boston, Washington e San Francisco – costituisce una realtà molto diversa dal resto del Nord America. E non solo perché a Manhattan e dintorni ci si è da tempo assuefatti al melting pot multirazziale e multiculturale che altrove risveglia paure ataviche, ma proprio perché la struttura della megalopoli è molto diversa.
Prendiamo l’aspetto dei trasporti e della mobilità, l’unico su cui posso esprimermi con qualche cognizione di causa: New York è una delle poche realtà oltre oceano in cui sia possibile fare a meno dell’automobile. Anzi, insistere ad utilizzarla, specie a Manhattan, può risultare abbastanza frustrante e molto costoso. Aspetti che non sarebbero sufficienti a disincentivarne l’uso se non esistesse la valida alternativa costituita da una superba rete di mezzi su rotaia.
L’idea corre subito alla vasta rete di subway – la metropolitana in gran parte, ma non esclusivamente, sotterranea che si estende per 400 chilometri e dal centro si spinge fino a Brooklyn, a Queens ed al Bronx (a Staten Island, il quinto borough raggiungibile in traghetto, funziona una linea separata) – La rete è imponente: venne realizzata nei primi decenni del Novecento, quando le infrastrutture destinate al trasporto pubblico rappresentavano una priorità, e per quasi un secolo, assieme a Londra e Parigi, costituì uno degli elementi essenziali che definivano la città del futuro.
Oggi è surclassata in fatto di estensione dalle megalopoli asiatiche, Pechino, Shanghai, Seoul e non solo. Da più di cinquant’anni subisce lo sfregio della microcriminalità e del degrado, richiamata da innumerevoli pellicole, come “I guerrieri della notte” e contrastato con qualche successo dalle misure di “tolleranza zero” al tempo di Rudolph Giuliani. Ma resta comunque una risorsa imprescindibile per chi vive o lavora nella Grande Mela.
Ci sono poi i treni relativamente veloci (nulla a che vedere con i Tgv o le nostre Frecce) che corrono lungo la costa atlantica, da Boston alla capitale, molto utilizzati dal Presidente Biden, che veniva soprannominato “Amtrak Joe” ed ora snobbati da Trump che fa sì il pendolare, ma sull’Air Force One tra la Casa Bianca e la residenza di Mar-a-Lago in Florida. Ciò che, invece, è meno conosciuta ed utilizzata dal turista europeo è la fitta maglia di ferrovie suburbane, che si estendono nel New Jersey, lungo il corso dell’Hudson verso Albany, capitale dell’Empire State, nel Connecticut e nell’intera Long Island, fino a località residenziali poste anche a 200 km da Manhattan.
Certo, per mantenere in buono stato ed estendere questo imponente patrimonio infrastrutturale sono necessari cospicui investimenti. Tra questi c’è l’Interborough Express (IBX), una ferrovia leggera di 14 miglia con 19 stazioni destinata a connettere Brooklyn e Queens, senza passare da Manhattan. Un po’ come le linee “orbitali” che si snodano attorno a Parigi e che hanno conosciuto un crescente successo. C’è l’East Side Access, un nuovo grande raccordo per spostare il terminal dei treni della Long Island Rail Road dalla Penn Station sotterranea e ormai intasata al Grand Central Terminal, che sarà pure la più vasta stazione del mondo (67 binari di testa su due piani), ma, dal tempo del declino dei treni passeggeri negli USA, è piuttosto sottoutilizzata.
Soprattutto, c’è il Getaway Program che include un nuovo tunnel sotto il fiume Hudson, indispensabile per potenziare il corridoio veloce lungo la costa atlantica, passando nel cuore di New York che continua a costituire il maggior bacino di utenza per i treni. Tutto ciò richiede ingenti risorse finanziarie e già si profila un braccio di ferro tra il governo federale (nonostante Trump sia di origini newyorkesi, non intende spendere troppo per la sua città) e l’amministrazione locale. Scontro in termini di miliardi di dollari, forse meno evocativo ma ben più strategico, delle dispute sui diritti “woke” che hanno caratterizzato la politica americana negli ultimi tempi.
Orbene, se nella vastissima area metropolitana che si estende attorno alla Grande Mela il trasporto su ferro riveste una tale importanza, viene da chiedersi perché ciò non avvenga in altre importanti città statunitensi, con la parziale eccezione della galassia di centri che si susseguono lungo la costa atlantica dalla capitale a Boston, all’area attorno a Chicago ed alla esotica San Francisco. In fondo, nella prima metà del Novecento, esistevano almeno 300 sistemi su rotaia (in buona parte tranviari) disseminati negli Stati Uniti.
Poi, nell’arco di appena vent’anni, quasi tutti vennero sacrificati, in nome del profitto (le compagnie ferroviarie continuavano a guadagnare solo nel trasporto merci), degli interessi che ruotavano attorno all’industria automobilistica (petrolio, asfalto, pneumatici e cemento). E, forse soprattutto, sull’onda dell’espansione a macchia d’olio delle aree urbanizzate per rincorrere il sogno americano della villetta in periferia, magari con piscina e naturalmente col proprio garage. Una scelta assolutamente energivora per il consumo del suolo in una nazione che pensava di poter contare su spazi sconfinati e poco densamente popolati.
Così, alla fine degli anni Sessanta, erano rimasti in funzione appena una dozzina di impianti su rotaia, che, ad eccezione appunto di New York, parevano un retaggio nostalgico di tempi ormai tramontati. Oggi nel Nord America sono presenti più di 50 sistemi su ferro per i passeggeri. Alcuni funzionano molto bene, come la metropolitana di Atlanta o le light rail di Denver e di Salt Lake City. Altri sono una presenza simbolica, come i nuovi tram di Cincinnati, El Paso o Little Rock. Questi interventi sono riusciti spesso a rivitalizzare i centri delle città che parevano destinati al degrado ed alla desertificazione serale, dopo la chiusura degli uffici nei grattacieli del downtown.
Tuttavia, nessuna metropoli è riuscita a riproporre un modello di mobilità incentrato su una vasta rete su ferro, anche se, in alcuni casi, si stanno sviluppando sistemi articolati di tutto rispetto, come a Dallas e Los Angeles, che da tempo ha cessato di essere una città percorribile solo in automobile.
Anche se persino i giovani americani sono meno sensibili al fascino delle quattro ruote che aveva stregato i loro nonni o genitori e talvolta rinunciano persino a prendere la patente. Resta il fatto che i treni di New York da soli movimentano più passeggeri di tutte le altre città Usa messe insieme.
Questo perché una volta disperse sul territorio residenze e posti di lavoro risulta poi molto difficile servirli in modo efficiente con il trasporto pubblico. E quindi la dipendenza dall’automobile, al cui uso si è costretti magari controvoglia, tende a divenire irreversibile. Dovrebbero rifletterci le città europee, che tra l’altro non dispongono di estese aree libere non ancora edificate e non possono sacrificare ulteriormente gli ormai residui spazi verdi.
La Pianura Padana – centri urbani e capannoni che si inseguono da Novara a Padova quasi senza soluzione di continuità – ne è un esempio.
Massimo Ferrari