Gianni, l’ultimo pastore di Feglino, da pochi anni riposa nella Casa del Padre, sicuramente in paradiso. Vogliamo ricordarlo con il suo racconto, che ci riporta al tempo in cui era bambino e viveva alla cascina di Prà Martin, nei pressi della cappella di San Giacomo. Grazie, Gianni, per il tuo esempio di Vita.
di Giuseppe Testa
 “Come ho già raccontato precedentemente fui l’ultimo pastore ad abbandonare quel tipo di vita, dura ma sana, tutto sommato poche decine di anni fa, ma che sembrano secoli, dopo l’accelerazione dello stile di vita. Io stesso quando ci penso mi sembra impossibile di essere appartenuto ad un passato prossimo ma che sembra già così remoto. Come tutti quelli che praticavano attività agro-pastorali, ci si affidava spesso al Cielo, perché ci mantenesse in salute, che ci aiutasse con il tempo propizio e favorisse la migliore raccolta dei frutti della terra. Quando, da casa mia, alzavamo lo sguardo verso il cielo per una supplica, prima di questo, i nostri occhi intercettavano il Passo e la piccola chiesa di san Giacomo (era a poche centinaia di metri alla spalle nostre), che si stagliava, e lo fa tuttora, come muta guardiana del versante, che parte dalla sommità dalla Colla fino ad abbracciare il mare. Era quindi naturale per la mia famiglia che questo fosse il nostro Santo di riferimento e soprattutto l’intermediario ideale per comunicare con l’Assoluto.
“Come ho già raccontato precedentemente fui l’ultimo pastore ad abbandonare quel tipo di vita, dura ma sana, tutto sommato poche decine di anni fa, ma che sembrano secoli, dopo l’accelerazione dello stile di vita. Io stesso quando ci penso mi sembra impossibile di essere appartenuto ad un passato prossimo ma che sembra già così remoto. Come tutti quelli che praticavano attività agro-pastorali, ci si affidava spesso al Cielo, perché ci mantenesse in salute, che ci aiutasse con il tempo propizio e favorisse la migliore raccolta dei frutti della terra. Quando, da casa mia, alzavamo lo sguardo verso il cielo per una supplica, prima di questo, i nostri occhi intercettavano il Passo e la piccola chiesa di san Giacomo (era a poche centinaia di metri alla spalle nostre), che si stagliava, e lo fa tuttora, come muta guardiana del versante, che parte dalla sommità dalla Colla fino ad abbracciare il mare. Era quindi naturale per la mia famiglia che questo fosse il nostro Santo di riferimento e soprattutto l’intermediario ideale per comunicare con l’Assoluto.
Era un territorio ostile in certi momenti, che non perdonava gli errori. I miei raccontavano di quella volta che un mulo è arrivato da solo, durante una terribile tormenta di neve. Il padrone, stremato, era morto congelato e fu ritrovato allo scioglimento della neve.
Io personalmente ricordo, e ne fui molto colpito, dalla bravata di tre giovani, di cui uno armato di fucile. Incontrato nei pressi della chiesetta tal “Stracchetta”, un anziano ex carcerato (aveva scontato 20 anni circa per un grave reato), cominciarono a schernirlo, minacciando di uccidergli il piccolo cagnetto di compagnia. L’uomo era anziano e quasi zoppo, si appoggiava ad un bastone ma camminava comunque con gran fatica e si faceva i fatti suoi. Ciò nonostante dallo scherno si arrivò alla fucilata, ed il cane fu ucciso sul colpo. Grande la disperazione ed il pianto dell’anziano, che si era visto uccidere l’amico animale. Anche per me fu una terribile esperienza, assistere a questa inutile ed infame bravata, alla morte della bestiolina ed ancora di più alla disperazione dell’uomo.
 Quando mi riparavo nella zona ricovero, quella che era l’antica chiesa, pensavo con rammarico a coloro che, sotto la soglia, avevano trovato la pentola col tesoro. Così raccontavano in casa. A quel tempo non c’era il camino a piano terra, ma era invece al primo piano, nelle stanze per l’eremita ed i viandanti. Oggi vi si accede con un ponticello esterno a nord, a quel tempo vi era una scaletta interna alla zona ricovero. Altre storie potrei raccontare, molte di ordinaria solitudine e dolore, però sono racconti ed esperienze in fondo analoghe a quelle dell’Italia rurale del primo Dopoguerra.
Quando mi riparavo nella zona ricovero, quella che era l’antica chiesa, pensavo con rammarico a coloro che, sotto la soglia, avevano trovato la pentola col tesoro. Così raccontavano in casa. A quel tempo non c’era il camino a piano terra, ma era invece al primo piano, nelle stanze per l’eremita ed i viandanti. Oggi vi si accede con un ponticello esterno a nord, a quel tempo vi era una scaletta interna alla zona ricovero. Altre storie potrei raccontare, molte di ordinaria solitudine e dolore, però sono racconti ed esperienze in fondo analoghe a quelle dell’Italia rurale del primo Dopoguerra.
Tutto quel territorio era al tempo destinato alla fienagione od al pascolo: ciò rendeva la campagna curata e familiare, a dispetto dell’abbandono di oggi che ne fa un luogo tetro, difficilmente penetrabile e poco invitante. I prati nei paraggi della chiesa erano ideali per il pascolo. Andavo volentieri a pascolare, perché all’inizio non ero solo. Altri bambini come me, spesso femmine, erano destinate a questo lavoro, tutto sommato leggero. Ricordo che aveva meno di 10 anni, ma c’erano bambini anche più piccoli. Eravamo inutili per lavori più pesanti, e potevano sgravare le nostre famiglie dall’importante compito della pastorizia, che ci dava latte, formaggi, carne e qualche soldo quando si vendevano gli agnellini. Il pascolo era l’occasione di vedere e scambiare due parole con questi coetanei, che arrivano da Cravarezza, Orco, Mallare o le Tagliate. Quante volte, nel trasporto del dialogo, ho perso di vista il gregge, ed ho faticato a ritrovarlo. Per qualche ragione a me oscura, se percepivano il maltempo in arrivo, velocemente risalivano il Monte Alto.
Con il batticuore, sapendo quanto fossero importanti per l’economia e la sopravvivenza della mia famiglia le cercavo affannosamente, finché le ritrovavo. Non oso pensare a quanto freddo, acqua, sole, temporali e vento ho preso in quegli anni. Oggi mi sembra impossibile, ma allora non mi pesava. Il tutto era bilanciato dalla pace, dal silenzio (dove emergevano i suoni della natura) e dalla profonda bellezza del territorio dove vivevo. Sogni ne avevo tanti dentro di me, ma non conoscevo la parola “stress”. C’era una piccola sorgente di acqua, nei pressi di un grosso scoglio panoramico, poco lontano dalla cappella. Con urla e fischi, potevo comunicare con i miei genitori, nella cascina in basso. Ora l’acqua è stata condotta da lontano e sgorga vicino alla chiesetta. Arriva dal territorio di Mallare, ed è captata nei pressi della cascina Costalonga.
A poco a poco, uno alla volta, i pastorelli hanno cambiato vita, e mi sono ritrovato solo.
 Poca la gente di passaggio, generalmente mulattieri, cacciatori o lavoratori stagionali. Aspettavo con ansia le feste patronali e religiose, che erano un momento raro di grande affluenza ma anche una rara occasione di incontrare mio cugino di Mallare. Ricordo però che quello della festa non era l’unico momento in cui la chiesa di San Giacomo, o meglio i suoi paraggi, erano luogo di incontro e di festa. Quando la stagione lo permetteva, dalla primavera inoltrata fini al termine dell’estate, la Colla diventava un punto di riferimento anche per le famiglie che abitavano le cascine di Orco, di Mallare e delle Tagliate (disseminate in un territorio molto vasto, erano numerose le famiglie che abitavano non proprio vicine, ma neanche troppo lontane dalla cappella. Le cascine feglinesi dei paraggi erano: Pra Martin, Gerutte, Bario, Ciappella, Strà ed il Groppo. Da Mallare arrivavano dalle cascine Benevento, Muntà, Cadotto fino agli abitati dell’Armitta (Eremita). Quattordici addirittura le famiglie che risiedevano alle Tagliate, molte di più erano quelle di Cravarezza, ma di queste ne venivano poche, per via dell’eccessiva lontananza.
Poca la gente di passaggio, generalmente mulattieri, cacciatori o lavoratori stagionali. Aspettavo con ansia le feste patronali e religiose, che erano un momento raro di grande affluenza ma anche una rara occasione di incontrare mio cugino di Mallare. Ricordo però che quello della festa non era l’unico momento in cui la chiesa di San Giacomo, o meglio i suoi paraggi, erano luogo di incontro e di festa. Quando la stagione lo permetteva, dalla primavera inoltrata fini al termine dell’estate, la Colla diventava un punto di riferimento anche per le famiglie che abitavano le cascine di Orco, di Mallare e delle Tagliate (disseminate in un territorio molto vasto, erano numerose le famiglie che abitavano non proprio vicine, ma neanche troppo lontane dalla cappella. Le cascine feglinesi dei paraggi erano: Pra Martin, Gerutte, Bario, Ciappella, Strà ed il Groppo. Da Mallare arrivavano dalle cascine Benevento, Muntà, Cadotto fino agli abitati dell’Armitta (Eremita). Quattordici addirittura le famiglie che risiedevano alle Tagliate, molte di più erano quelle di Cravarezza, ma di queste ne venivano poche, per via dell’eccessiva lontananza.
Un pomeriggio di festa, nato spontaneamente, ma soprattutto di socialità, che leniva l’impegno di una vita dura e solitaria. In tempi senza telefono questa occasione riuniva persone molto distanti tra loro, le metteva in relazione, cosa che non era possibile essendo le cascine isolate, e la gestione delle attività agro-pastorali impegnativa. Si ricreava una comunità allargata, non per appartenenza ad un confine amministrativo, ma che condivideva la dura vita della cascina e della montagna.
Fu ricavato una spiazzo adeguatamente in piano, vicino alla chiesa, per potere ballare. Ricordo la domenica pomeriggio un feglinese, Oliveri Adolfo detto Gustin, il quale portava una botte di vino (una barrique di 45 lt) col mulo, insieme a panini al salame, improvvisando una osteria campestre. Su non mancava mai la musica, suonata con organetti di fortuna o con la fisarmoniche di Emilio l’Orbu (completamente cieco per un infortunio accadutogli quando era bambino). Riconoscevo il suono del suo bastone sul ciottolato, che anticipava il suo arrivo. Oltre a suonare, era in grado di andare da solo da Cravarezza alle Manie, a trovare dei parenti. Perse questa straordinaria capacità quando allargarono e asfaltarono le strade, cancellando i suoi riferimenti.
Alla domenica pomeriggio i prati si riempivano, ed a me sembrava un sogno: immaginavo tutta questa gente che veniva a trovarmi a casa, perché mi sentivo a casa. In effetti la mia cascina era la più vicina. Ricordo un terribile temporale improvviso, con tuoni e fulmini che cadevano nei pressi, una domenica durante il ballo… Il piccolo rifugio non riusciva a contenere tutti, ormai fradici e impossibilitati a riparare in qualche posto coperto. Io e la mia famiglia ci rifugiammo a casa, bagnati ed impauriti dopo una lunga corsa.
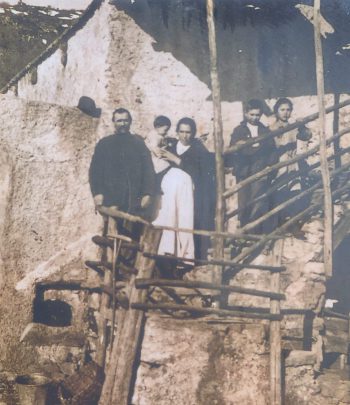 La chiesa, o meglio il rustico rifugio, era abitato a quel tempo da un pastore, e dalle sue capre. Giaccu de Crave (Giacomo delle capre). La chiesa era sempre chiusa, salvo le feste, ed aveva i vetri rotti. Avevano più volte provveduto a sostituirli, ma mani sacrileghe e dispettose continuavano a romperli. In quelle occasioni rimaneva chiusa, ma vedevo che la gente, spesso le donne, pregavano inginocchiate dal di fuori e lasciavano fiori. La porta che dava accesso era ancora sotto il porticato, a sinistra. Era quella della chiesa precedente, l’unica munita di serratura. La porta all’epoca principale per accedere ai riti è la stessa di oggi, ma era senza serratura.
La chiesa, o meglio il rustico rifugio, era abitato a quel tempo da un pastore, e dalle sue capre. Giaccu de Crave (Giacomo delle capre). La chiesa era sempre chiusa, salvo le feste, ed aveva i vetri rotti. Avevano più volte provveduto a sostituirli, ma mani sacrileghe e dispettose continuavano a romperli. In quelle occasioni rimaneva chiusa, ma vedevo che la gente, spesso le donne, pregavano inginocchiate dal di fuori e lasciavano fiori. La porta che dava accesso era ancora sotto il porticato, a sinistra. Era quella della chiesa precedente, l’unica munita di serratura. La porta all’epoca principale per accedere ai riti è la stessa di oggi, ma era senza serratura.
Ricordo ancora la sagoma longilinea di don Revello che si presentò un dì a casa nostra. Ci chiese una scala per sistemare alcune tegole, che il vento aveva sollevato. Non ci restituì mai la scala, ma la stessa venne da allora usata per puntellare la porta sprovvista di serratura, affinchè non si potesse aprire. Per molto tempo si continuò ad accedere dalla vecchia soglia, per poi rimuovere il puntello.
Nelle feste religiose ufficiali c’era molta più gente. I Mallaresi installavano su due “osterie da campo”, rigorosamente sul confine ma appena nel loro territorio, alle quali tutti però potevano accedere. Erano quelli del “Cadotto”, e quelli dell’osteria “Mezza Montà” guidati da Armando, due osterie che erano abbastanza vicine al passo (Il Cadotto è all’inizio del tratto in salita, l’altra è, come dice il nome, a metà salita). I Feglinesi venivano su già con la merenda, e non vi era nessuna osteria feglinese (che peraltro distavano molto), che si impegnava a fare altrettanto. Io ero contento perché c’era il banchetto di Berruti Gino, detto “Garbasso”, un ambulante che vendeva caramelle e noccioline.
Quante risse! Pugni, calci e camice strappate, al massimo qualche bottigliata in testa. Ricordo ancora i racconti di mio padre, che narravano di don Antonio di Mallare (era prima della guerra), un omone grande e grosso che, dopo aver mangiato e bevuto, poi dava il suo “importante” contributo pro-mallarese alle risse. Egli era su non in veste ufficiale, in quanto le funzioni religiose erano esclusivamente celebrate da preti di Feglino. Anche queste feste, con l’abbandono dei “cascinari”, lentamente si esaurirono. Erano circa gli anni ’60. La vita più comoda ed il lavoro in fabbrica avevano sedotto (e chi può negarlo?) e la nostra campagna (quasi montagna) si spopolò.
 La domenica non ci si incontrava più per ballare, ma nacque ancora per un po’ di tempo una occasione di incontro e di scontro tra i giovani dei due versanti, segno che questo luogo, che da sempre univa, era entrato nel cuore e nel vissuto della gente, che non voleva recidere del tutto questo filo che collegava al passato. I prati di San Giacomo diventarono un campo di calcio, dove i giovani dei due paesi si sfidavano in accanite partite di pallone. Ricordo che spesso, quasi sempre, eravamo noi Feglinesi a vincere …
La domenica non ci si incontrava più per ballare, ma nacque ancora per un po’ di tempo una occasione di incontro e di scontro tra i giovani dei due versanti, segno che questo luogo, che da sempre univa, era entrato nel cuore e nel vissuto della gente, che non voleva recidere del tutto questo filo che collegava al passato. I prati di San Giacomo diventarono un campo di calcio, dove i giovani dei due paesi si sfidavano in accanite partite di pallone. Ricordo che spesso, quasi sempre, eravamo noi Feglinesi a vincere …
Cerco sempre l’occasione per tornare a fare un giro in quei luoghi pieni di ricordi. Mi colpisce molto vedere lo straordinario cambiamento del paesaggio, senza la mano dell’uomo che lo cura, e ancor di più vedere le cascine ridotte a rudere. Cerco tra le spine e la macchia gli alberi da frutto, nei pressi della mia cascina, piantati da mio padre o mio nonno, che sopravvivono a stento all’abbraccio dei rovi che li soffocano. Mi verrebbe voglia di risistemare tutto ma … ormai tocca a qualcun altro.
Io ho approfittato di questo racconto per risistemare e toglier le ragnatele dai miei ricordi: in quell’eterno presente onirico in cui mi piace vagare ogni tanto. Lì è ancora tutto a posto come allora, e mi sembra di sentire ancora la voce di mia madre o il sordo e costante rumore della zappa di mio padre. Infine riemerge l’allegro belare delle mie pecorelle, che mi stanno aspettando per essere portate al pascolo, lassù, intorno alla cappella di San Giacomo. Gli animali mi stanno chiamando, è l’ora di andare verso la Colla a cercare erba fresca…”
Giuseppe Testa




