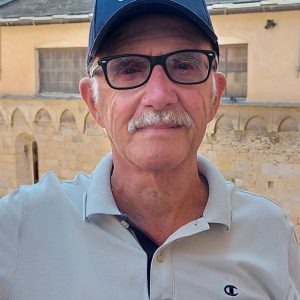1625 – 2025, quattro secoli fa la guerra fra il Ducato di Savoia e la Repubblica di Genova, con alcuni accadimenti savonesi e la “civitas fidelissima” di Oneglia.
di Ezio Marinoni

In un periodo in cui i fuochi di guerra sfiorano di nuovo l’Europa, in un nuovo scenario geopolitico impensabile sino a pochi anni fa, possiamo ricordare un fatto avvenuto nel 1625, che ha sconvolto le terre di Liguria, con una tentata invasione proveniente da nord.
Sono trascorsi quattrocento anni, la memoria si è cancellata e anche i libri di storia sono avari di notizie. Di questa lontana guerra, cruenta a tratti, sempre con vite umane sprecate su un fronte itinerante che si spostava per desiderio dei potenti e dei regnanti del tempo (la Repubblica di Genova, da un lato, e il Ducato di Savoia, dall’altro) narra alcune notizie Carlo Bruzzo in una pubblicazione da archivio, Note sulla guerra del 1625, contenuta nel volume del 1938 della Società Ligure di Storia Patria (pagg. 155 – 210).
La guerra inizia, scrive Bruzzo, « in seguito alle controversie per il possesso del Marchesato di Zuccarello fra la Repubblica di Genova e il Duca di Savoia Carlo Emanuele I, alleato con il Re di Francia. »
Al Ducato di Savoia, infatti, non basta il possesso in Liguria del Marchesato di Zuccarello e della città di Oneglia, “civitas fidelissima” di Casa Savoia…
Al riguardo, cfr. articolo su storia di Oneglia, Trucioli, Anno XI, numero 41 del 8 giugno 2023:
La Repubblica di Genova subisce le rotte di Rossiglione (27 marzo) e di Voltaggio (9 aprile); dopo la sconfitta di Pieve (11 maggio) deve abbandonare al nemico « tutta la Riviera di Ponente da Albenga a Ventimiglia; in seguito le sorti mutarono perchè i dissidi fra il Duca e il Maresciallo di Lesdiguières (1) comandante delle forze francesi sul modo di proseguire le operazioni impedirono ai collegati di sfruttare subito i successi ottenuti e diedero tempo alla Repubblica di ricevere soccorsi, finché la entrata in campagna del Duca di Feria, governatore spagnuolo di Milano, che da Alessandria minacciava le retrovie dei collegati, indusse questi a ritirarsi, lasciando nelle fortezze piccoli presidi che poco dopo furono facile preda alle forze della Repubblica (nel Luglio rioccuparono Novi, Ovada e Gavi). »
Il Doge Gerolamo De Franchi Toso si dimette il 16 giugno 1625, gli succede Giacomo Lomellini.
Nei mesi successivi, cambia tutto.
« Una spedizione guidata dal Maestro di Campo Generale Brancaccio e dal Marchese di Santa Croce comandante delle galere di Spagna, potè ugualmente con facilità riconquistare prima della fine dell’anno tutta la Riviera di Ponente e occupare anche molte terre appartenenti al Duca di Savoia, le quali però furono restituite quando dopo lunghe trattative si stipulò il trattato definitivo di pace nel 1633. »
Per tutelare i propri confini dagli invasori, la Repubblica nomina Commissari alle Armi, per la durata di tre mesi, e li invia sul territorio con funzioni di comandanti di zona, con disuguaglianze evidenti da zona a zona: a Portofino la giurisdizione si limita al castello, la valle del Bisagno e la valle Scrivia hanno un solo comandate ciascuna.
« Fra le numerose relazioni merita di essere ricordata quella inviata il 18 Gennaio da Bernardo Giustiniani sui luoghi di Porto Maurizio, San Remo, Taggia, Triora, Castelfranco, Ventimiglia, Bordighera e La Penna.
Per ciascuno dei luoghi l’autore considera « lo stato attuale delle opere di difesa, ricerca le posizioni avanzate, indica i presidi e i materiali necessari e infine esamina, con particolare attenzione per Ventimiglia e Triora che erano i luoghi più esposti, i passi dei monti e le strade utilizzabili dal nemico proveniente dal Piemonte o dalla Contea di Nizza. »
Non si tratta certamente di letteratura di viaggio o alla stregua di un Grand Tour, ma è un arcaico esempio di descrizione dei luoghi, sia pure commissionato a scopi militari, che descrive i luoghi del territorio ligure.
Il testo si sofferma, poi, a dettagliare le condizione della truppa e lo stato delle Milizie, antica istituzione genovese, durata fino alla sua caduta. Anche in questo caso, lo scritto è un punto miliare.
Scrive il Bracco: « Per quanto è a mia conoscenza nessuno se ne è mai occupato in modo particolare, per ricercarne le origini e studiarne le vicende in tutti i successivi tempi, sarebbe questo un argomento meritevole di attenzione anche per metterlo in confronto con le analoghe istituzioni delle altre regioni d’Italia. Le presenti note si limitano a considerare lo stato delle Milizie nella guerra del 1625 quale risulta dai documenti di quell’anno. »
Molte le fortificazioni nella regione. In particolare, a Savona,
« Si formò una serie di fortini staccati sulle alture che sovrastano alla città (posizioni dette I Cappuccini, Costa di S. Chiara, Loreto, M. Albano e diverse altre) e si distese una trincea continua davanti alle vecchie mura verso il torrente Letimbro; con alcuni posti isolati si collegò nel piano la città con la fortezza di Vado ove al già esistente forte di San Lorenzo si aggiunsero altre difese più in alto a Santo Stefano.»
Grazie a questa descrizione, abbiamo una mappa inedita della città di Savona e immaginiamo, di conseguenza, un panorama non più visibile, dove perfino le antiche mura giocano un ruolo.
In questo contesto, piccolo mistero, ci chiediamo chi fosse il «Prete Paolo Rizzo, che lavorò specialmente a Savona », il cui nome appare nelle carte come Rizzo, Risso e Riccio.
Quali altri misteri e segreti si celavano dietro le quinti di una guerra?Nelle carte genovesi del 1625 si trovano due accenni ai veleni. « Il primo è un memoriale con la data del 12 Marzo che il Medico Ottavio Camilla, rispondendo ad un quesito fattogli, rivolge al Doge. (…)
Un altro accenno all’uso si ha in una proposta di introdurre veleno nel pane fatta dal M.co Camillo Mercante che dalla Repubblica era stato inviato a Serravalle per osservare il nemico che aveva occupato Novi, Gavi e altri luoghi e mandare informazioni sulle sue forze, sulle sue mosse e prevedibili intenzioni.»
L’andamento altalenante della guerra favorisce le capitolazioni delle fortezze (come il castello di San Paolo a Ventimiglia).
Come in ogni guerra, i danni inferti alla popolazione sono molti.
«Un primo peso alle popolazioni aveva nell’obbligo di fornire l’alloggio; esso già sempre fastidioso per sè stesso si trovava aggravato dalle esigenze e prepotenze dei soldati. »
La lezione del passato non migliora il presente, è evidente. E la guerra serpeggia di nuovo, come un nemico silenzioso e sempre in agguato.
L’immagine di copertina, tratta da wikipedia, è il quadro “Il Marchese di Santa Cruz porta rinforzi a Genova e viene accolto dal Doge”, di Antonio de Pereda, esposto al Museo del Prado.
Ezio Marinoni
Note
(1) Nella carte genovesi il nome del comandante è italianizzato in La Diguera o Aldiguera. In un proclama agli abitanti di Gavi, del 6 maggio 1625, egli si definisce e nomina “Francois de Bonne Duc de Lesdiguières et Connestable de France Comandant l’armé du Roy deca des monts”.