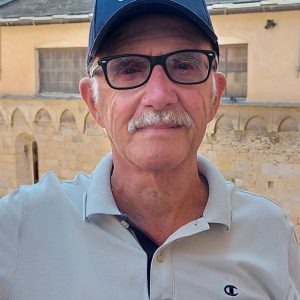Alla ricerca di Strade Romane. La Viabilità Romana nel Finale e nelle zone limitrofe: tante domande e poche risposte.
di Giuseppe Testa
Per chi andava a scuola al tempo della lavagna, del gesso e del cancellino: vi ricordate quando la lavagna era tutta scritta e doveva necessariamente essere cancellata, per scrivere altre cose ricominciando da capo? Questo è l’esempio di ciò che dovremmo fare quando parliamo di viabilità Romana, visto che è stato scritto tutto ed il contrario di tutto… cancellare e ricominciare a scrivere con una nuova mentalità.
- Poche cose affascinano come la ricerca e lo studio della viabilità romana e del suo corretto posizionamento sul territorio. In Liguria, e nel Finalese in particolare, è però molto difficile risalire con certezza alla sua esatta identificazione. Di conseguenza, la rete della viabilità romana che attraversava il nostro territorio rimane ancora oggi in gran parte misteriosa. Di ciò ne sono causa la complicata orografia che, seppure permettendo poche possibilità di transito, vista la continuità di utilizzo in età medievale e moderna, a fatto si che il sedime originario è stato, più volte, rifatto, sostituito o ricoperto completamente da quello nuovo, cancellando le fasi antecedenti. Le fasi di utilizzo successive possono avere inoltre modificato, seppur lievemente, il percorso originario, per asservirlo alle variazioni degli insediamenti, alterando e facendo perder il tracciato originale. Il territorio impervio e difficile, instabile a livello di frane, paleofrane e smottamenti, dalla difficile morfologia e condizionato da numerosi fattori, ha fatto si che le acque meteoriche, favorite da grandi bacini imbriferi, scorrano a volte con grande violenza erosiva, con gravi modifiche non solo alle strade ma al territorio stesso. A ciò si aggiungano la scarsità di documentazione scritta e le ricerche isolate e non sistematiche intraprese dagli storici.
- La difficoltà di studio riguarda sia le grandi arterie, sia la moltitudine di vie minori, di cui si fatica a comprendere la funzione nel sistema viario.
- In generale, nelle nostre zone la maggior parte di strade romane erano mulattiere e questo le hanno rese più esposte a frane e smottamenti, fenomeni inesistenti nei tratti in pianura, dove si possono verificare quelli di interramento di varia natura. Qui è più facile, per esempio eseguendo scavi cittadini, ritrovare vecchie strade a livelli più bassi.
Erano due le arterie di primaria importanza che hanno attraversato il Finalese: la Via Aurelia e la via Julia Augusta. Le due strade furono costruite in periodi diversi, ma probabilmente per un certo periodo furono in uso contemporaneamente. Non è escluso che in taluni tratti si sovrapponessero.
Sono molti gli studiosi che si sono appassionati alla loro ricerca ed identificazione, ognuno dei quali ha portato uno o più contributi di un certo interesse, anche se alla fine rimangono molte le ipotesi, tutte in parte condivisibili. Restiamo in attesa che improbabili nuovi documenti vengano ritrovati, o che casuali e fortunati scavi archeologici ci diano qualche ulteriore tassello in un quadro così povero di indizi. Poche e scarne sono le fonti documentarie, itinerari, epistole o altro, che ci documentano dell’esistenza di strade in Liguria, come ad esempio le lettere di Bruto e Ventidio riferibili al territorio Vadese. Spesso la pur preziosa citazione, se da un lato ci da notizia dell’esistenza della strada, dall’altra non consente comunque la sua localizzazione sul territorio. Oggi, nella stragrande maggioranza, le vie che si ipotizzano come romane sono l’evoluzione degli antichi tracciati: sono strette, con ciottolati medievali o moderni, a volte ricoperte di asfalto, e probabilmente non ricalcano completamente il tracciato originario, ma quello in cui una serie di episodi, causati dall’Uomo o di origine naturale, lo hanno modificato.
Che cosa si intende per strada romana?- Generalmente, esiste molta confusione su ciò che si intende per strade romane. Ci vengono in mente solo le grandi vie consolari e imperiali: su di esse non solo si muoveva con rapidità l’esercito, ma anche il servizio postale ed i commerci, agevolati spesso dalle caratteristiche di carrabilità. In realtà la viabilità romana era abbastanza complessa e comprendeva molti status diversi. Dobbiamo considerarla come un sistema complesso, paragonabile a quello di oggi: strade maggiori, minori, locali, raccordi, percorsi commerciali e militari, fino al più piccole vie private (vedi l’elenco in fondo). A seconda dell’importanza, la strada veniva finanziata e mantenuta da appositi organi preposti, ma era dismessa se la sua importanza veniva meno per vari motivi. In primo luogo, con la penetrazione militare, fu l’esercito che progettava, costruiva e manteneva le vie dette “d’arroccamento” (via militare parallela ad una zona strategica o di guerra, che consente lo spostamento rapido e sicuro delle truppe). Per il loro scopo militare, queste vie dovevano essere essenziali nella struttura ed adatte ad essere velocemente percorse. Successivamente, opportunamente allargate ed a volte modificate nel tracciato, esse vennero dotate delle necessarie infrastrutture ed adattate anche per gli scambi commerciali. Per quanto riguarda la viabilità preesistente, se giudicata idonea alle esigenze dei conquistatori, essa veniva opportunamente adeguata ai criteri costruttivi romani. Vi erano quindi una serie di strade paragonabili alle nostre “provinciali” e “regionali”. Anche i fondi agricoli più importanti, avevano una viabilità interna a carico del proprietario. Infine, c’erano i veri gioielli dei Romani: le vie consolari e, in seguito, quelle imperiali. Queste erano vere e proprie strade interregionali e spesso internazionali, costruite con criteri particolari. Il rapido sviluppo della potenza di Roma rese indispensabile progettare e realizzare un sistema di comunicazione terrestre a lunga percorrenza, in grado di consentire veloci spostamenti di truppe tra le province dell’Impero, per il servizio postale ed anche idonee agli scambi commerciali.
Molte di queste, con viadotti, ponti ed altro, esistono ancora oggi in molte zone di quello che fu l’Impero. È più facile ritrovare ponti o tracce di ponti in posizioni più elevate, in quanto scarsa o nulla l’azione erosiva delle acque, mentre a fondovalle od in pianura è, per opposti motivi, molto difficile. L’amministrazione delle vie fu un settore molto importante, affidato ai curatores viarium che in base alla lex sempronia viarum del 123 a.C. e dovuta a C. Gracco, dovevano provvedere alla manutenzione e a garantire una perfetta viabilità. Purtroppo il testo integrale della legge non ci è pervenuto, ma solo piccole parti in citazioni.
Prima di ricercare una strada Romana- Quando un ricercatore decide di affrontare uno studio, si inizia a porre un certo numero di domande, alle quali dovrà cercare delle risposte. Per avere risposte giuste, è però importante porsi domande giuste: probabilmente il fatto che poco sappiamo dello sviluppo della rete stradale romana è perché ci siamo fatti delle domande sbagliate, o siamo partiti da presupposti sbagliati. Molto spesso è il “campanilismo” del ricercatore locale che fa partire la ricerca col piede sbagliato: è il caso di Pollupice, reclamato da numerosi paesi nel proprio territorio. Prima di iniziare a ragionare sull’argomento è giusto stabilire dei punti fermi, derivati da dati oggettivi.
Primo e importantissimo: i Romani hanno avuto il controllo sul Finale per quasi un millennio: dalla conquista del 181 a. C. alla disfatta del 643, a causa di Rotari. Probabilmente dall’invasione dei Goti, fino all’arrivo di Rotari, la macchina amministrativa non era più perfetta, ma vale la pena sottolineare la lunga presenza sul territorio, che ha permesso a tutte le strade, sentieri, vie di essere adeguate alle leggi Romane. Una seconda cosa su cui voglio ritornare è che esisteva (come oggi d’altra parte), la viabilità maggiore ed una minore. Quando cerchiamo una strada romana, generalmente intendiamo vie Consolari (di età repubblicana), o vie Imperiali, e la presenza sul territorio di tracce di lastricati od altro non ci deve trarre in inganno, perché potrebbero essere reliquie di strade minori.
Sono numerose le vie che dal Medioevo in avanti, a torto o ragione, vengono chiamate vie romane o romere, stratae, ecc. La toponomastica può essere indicativa ma va accuratamente verificata.
Ogni tipo di strada doveva avere certe caratteristiche costruttive, e determinate infrastrutture: larghezza, eventuali miliari (ogni 1000 passi di distanza, circa 1,5 chilometri, veniva posta una colonna cilindrica indicante il numero del miglio e il nome del magistrato – censore, console o imperatore – che ne aveva ordinato la costruzione), mansioni o mutazioni, tipo di fondo, poteva avere monumenti funebri o necropoli nei pressi, e altre caratteristiche o elementi utili alla sua localizzazione. Se si ha la fortuna di ritrovare parti di strada, grazie ai suoi parametri (larghezza, fondo, particolari costruttivi) potremo ipotizzare una prima identificazione. Ritrovare dei miliari in situ sarebbe l’ideale. Ancor prima di tutto dovremo ragionare su chi l’ha costruita e perchè. Per esempio, cambierebbe sicuramente la sua posizione se la via Julia Augusta fosse stata progettata ed eseguita come strada militare (doveva puntare dritta e veloce alle “zone calde”). Dovendo collegare Tortona ad Arles, che senso aveva farla arrivare allora fino a Vado, attraverso passaggi impegnativi (bastava una bretella), e poi nel Finalese (un territorio impervio), costringendo le truppe ad un percorso inutile e faticoso, quando sarebbe stato comodo bastato dalla Val Bormida puntare già sulla Liguria di Ponente? Sarebbe da indagare se, nel diritto romano, una via militare fosse percorribile solo all’esercito, insieme al cursus publicus, o il transito fosse permesso a tutti, magari con un lasciapassare specifico, ecc. Se fosse stata concepita per l’uso civile, il suo tracciato doveva unire insediamenti (non quelli che esistono oggi, ma quelli di allora, che comunque non erano molti) e scali marittimi: essa avrebbe dovuto supportare la navigazione di cabotaggio nella brutta stagione, tramite raccordi detti diverticula. Poteva essere anche ad uso misto civile/militare, cioè dopo essere stata nata come strada militare, venuto meno il bisogno di controllare la Gallia Narbonense, essere aperta ai traffici. Il motivo della sua costruzione cambierebbe quindi il suo sviluppo: come strada militare dovrebbe essere cercata non sulla costa ma più nell’entroterra, e viceversa nell’altro caso. Un esempio di strada militare è la cosiddetta Flaminia militare, ritrovata pochi anni or sono, che unisce Bologna ed Arezzo e che si sviluppa sugli appennini ad una quota di 800 metri. Pacificata la zona fu abbandonata. Usata dai pellegrini, se ne persero le tracce fino alla riscoperta, sotto mezzo metro di terra, pochi anni fa. Poi, siamo sicuri che la via Julia Augusta fosse tutta carrabile, o in certi tratti impegnativi fosse una mulattiera?
- Che problemi si incontrano nel cercare una strada romana?
È indubbio che qualsiasi studioso di viabilità romana incontri grandi difficoltà a rinvenire strade romane nella loro integrità. Infatti nella stragrande maggioranza dei casi si cerca una cosa celata alla vista, e di cui si ignora la posizione. Si inizia ad indagare le indispensabili fonti documentarie, gli itinerari, e cosa hanno scritto gli studiosi del passato. Si verifica la toponomastica, ci si informa dell’eventuale ritrovamento nei tempi di monumenti, costruzioni, monete, oggetti, sepolture ed altro ascrivibili all’età Romana. Poi si fanno una serie di ricognizioni sul territorio, iniziando a sviluppare delle tesi personali (ma essere sempre pronti a ricredersi), verificando nel contempo anche le tesi degli altri studiosi. Ricorrendo poi a geologi, botanici ed altri tecnici specializzati bisogna cercare di capire come fosse il territorio 2000 anni fa, per non cadere nell’errore di “pensare” la strada nel contesto odierno, ma ricostruendo quello di allora. Variando il corso dei fiumi nei secoli, a volte si ritrovano ponti interrati nei campi, e lontani dai letti odierni. Stesso discorso per le litoranee: quale era la linea di costa venti secoli fa? Quali e dove erano gli insediamenti romani, i porti, e quali i commerci?
Per ritrovare delle strade bisogna conoscere le tecniche costruttive e la filosofia pratica di come i Romani intendevano la sua progettazione ed il loro sviluppo.
- Il concetto più importante per loro era sviluppare il percorso nel modo più rettilineo possibile. Le strade romane, per quanto ne sappiamo attualmente, non prevedevano l’uso dei tornanti nei percorsi alpini. Spesso, addirittura, era conveniente che la grande arteria diventasse mulattiera nei tratti montani, (qui si trasbordavano merci e passeggeri a dorso di animali da soma), per ritornare carrozzabile al di là dell’asperità. Quali erano, ad esempio, le pendenze massime consentite? Le variazioni di direzione non seguivano un andamento curvilineo, ma erano segmentate a retta. Il traffico su ruota, comunque modesto, percorreva il centro della carreggiata, per spostarsi solo in caso di incrocio con un altro veicolo. Nelle strade urbane o in quelle maggiori esistevano a brevi distanze gradini per permettere le salite e le discese da cavallo, ecc.
Comunque il massimo che si può sperare di trovare sono tratti di “strata”, magari ponti o ruderi di ponti, o segmenti di tracciato in prossimità di insediamenti scavati archeologicamente. Per assurdo, gli unici tratti intatti di strata originaria rinvenibili sono quelli abbandonati per cause accidentali quando erano ancora in uso, o poco dopo (ad esempio, tratti completamente abbandonati, coperti da interramenti alluvionali, da frane o dalla terra portata dai contadini, per formare delle fasce da coltivare). Questi eventi, voluti o accidentali, hanno bloccato il sedime stradale all’epoca dell’evento, mentre i tratti di strade romane che hanno avuto continuità d’uso hanno subito una serie di modifiche, sia nei manufatti che nel percorso, tali da diventare, nel corso di un millennio e mezzo, irriconoscibili. A parte gli eventi storici maggiori, una serie di cause minori ha impedito a molte strade di arrivare fino a noi. Venendo meno l’Impero, è venuto meno il senso per cui queste strade (le maggiori) furono create, per cui il potere politico le ha dimenticate. Qualcuna ha funzionato a livello locale, altre finirono lentamente nell’oblio. Tra queste vi furono: il lento restringimento di carreggiata, capace di ridurre una Via Imperiale a mulattiera; tale intervento fu causato dai periodici rifacimenti per qualche crollo dei muri a monte ed a valle. Per di più, in assenza di un controllo costante da parte dell’autorità, era facile che i proprietari confinanti si appropriassero lentamente di porzioni di terreno sottratto alla carreggiata. In secondo luogo vi furono piccole modifiche di tracciato, dovute alla necessità di raccordarsi con nuovi insediamenti.
Le frane, altri piccoli eventi atmosferici o la caduta di un grosso albero potevano in taluni casi sconsigliare di ripristinare un tratto, rendendo più conveniente la tracciatura di un tratto alternativo, a volte reso tale solo dalla consuetudine del continuo transito. Nei tratti continuamente in uso, i periodici rifacimenti del basolato originario hanno cancellato il manufatto romano. Un ritrovamento archeologico è un caso raro, ma ci da una conferma sicura. Qualora vengano individuati una serie di tratti certi, ascrivibili all’età romana, questi si possono raccordare fra di loro, nel rispetto dell’orografia del territorio, e lo studioso riesce così ad ipotizzare un percorso attendibile.
Quanto dovremmo attendere nel Finalese per definire l’esatta localizzazione della via Aurelia e Julia Augusta? Credo che lo studioso di storia da solo sia insufficiente, e che sia l’ora di iniziare una ricerca multi-tematica. Al giorno d’oggi l’evoluzione dei sistemi di indagine fa intravedere nuove possibilità: indagini materiche, foto aeree agli infrarossi, georadar capaci di indagare il terreno fino a 7 metri di profondità, ed altro. A ciò va aggiunto un modo moderno e completo di indagare: per iniziare bisognerebbe ricercare e segnare su una carta topografica tutti gli insediamenti noti di età romana, i ritrovamenti di monete o oggetti, le necropoli, e tutto ciò che è ascrivile al tempo. Bisognerebbe studiare il diritto romano, quello noto, legato alla viabilità: interessanti studi sono stati eseguiti. Dovremmo fare nostra il “concetto” di strada degli ingegneri romani e le tecniche costruttive usate, studiare tutti i documenti noti e ricercarne altri. Una attenzione particolare, come già detto, sarebbe quella di stabilire come si presentava il territorio allora, compito questo di geologi e botanici. Anche lo studio della prima cristianizzazione può dare elementi utili, ricercando gli antichi luoghi di culto che sorgevano sulle vie pubbliche. Questi sono una serie di esempi di ricerca integrata, serie che si può allargare. L’auspicio è allora quello che si possa creare un gruppo di lavoro, formato da diverse “professionalità”, ognuna delle quali possa portare il suo contributo.
C’è strada e strada- Dal complesso delle testimonianze dell’epoca romana si può dedurre che la via, etimologicamente associata a vehere (trasportare, portare), veniva normalmente identificata come una linea o strada aperta alla circolazione dei mezzi, dove non più di due carri si potevano incrociare.
L’actus, da agere, andare, avanzare, era un’altra specie di cammino la cui ampiezza arrivava solo a 4 piedi; consentiva il passaggio solo di bestiame o di veicoli uno dietro l’altro.
L’iter, da ire, andare, spostarsi da un posto a un altro, era ampio 2 piedi e non era praticato da tutti, ma solo da pedoni e cavalli.
La semita, la cui ampiezza non era più della meta – semis – di quella dell’iter, approssimativamente un piede, era una semplice stradina, sentiero, e in citta, una viuzza che circondava le case.
Bisogna infine ricordare come in fonti di provenienza eterogenea si ritrovano talvolta, come sinonimi del termine via in senso stretto, varie espressioni:
-Agger : cammino in pietra o pavimentato in qualche modo, carreggiata.
–Callis: era un cammino, stradina, sentiero, tracciato in montagna per il transito del gregge.
-Trames: scorciatoia, o traversa.
-Diverticulum: cammino appartato e tortuoso, deviazione.
-Vicus: era la strada di citta, urbana, viae urbicae o vici. Vicus era
utilizzato anche nel significato di villaggio.
-Clivus: strada o sentiero in pendenza.
-Ambitus: parte curvilinea di tracciato stradale, piccole stradine che attorniavano le case in citta, formando un perimetro di 5 piedi di ampiezza.
-Angiportus: strada piccola e stretta.
-Platea: strada ampia, piazza pubblica.
-Comprendiaria via/compendium: scorciatoia.
Nei documenti medioevali con il termine strata si intendeva generalmente una vecchia via romana lastricata. Compare dopo la dicitura “strada romera o romea”, che però, dopo i secoli dei grandi pellegrinaggi, potrebbe indicare anche una delle tante vie preferenziali scelte dai “Romei” per andare o tornare dall’Urbe.
A differenza delle sofisticate tecniche usate dai Romani, nel Medioevo le strade erano semplici percorsi con il sedime arginato e sollevato, per permettere il defluimento delle acque piovane. Alcuni studiosi del passato le hanno erroneamente confuse con le strade definite dalla parola “levatae”, che appare nei documenti medievali. Oggi si è propensi ad attribuire alla voce in questione la collocazione al periodo romano quando, nei tratti pianeggianti, l’ultimo strato del sedime era, per sottrarlo agli allagamenti, elevato rispetto al terreno (Levata: termine in uso in età antica per indicare le vie consolari romane, elevate rispetto al territorio adiacente). Esistono documenti dell’epoca, specialmente atti notarili, dove viene usato contemporaneamente sia il termine “strata”, sia “via” o “levata”, a dimostrazione del differente status tra le vie.
Giuseppe Testa