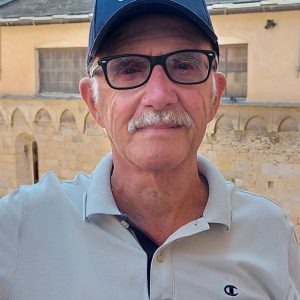Tosse, frazione di Noli, località Ca’ di Badin, 12 agosto 1944. Cosa sia successo quell’afoso giorno di agosto alle spalle di Spotorno e Noli pochi lo sanno.

 Come mai gli aerei alleati hanno sganciato nell’entroterra? Quale era il vero bersaglio? Qualcuno dice che erano missioni “diversive”, per distrarre il nemico, mentre si preparava uno sbarco altrove, o che il vero obiettivo era Spotorno, forse la ferrovia. Vero è che le azioni sui civili servivano a minare il morale della popolazione, ma le numerose bombe sganciate in quell’occasione erano praticamente in campagna, alle spalle dei centri rivieraschi. Quindi errore dei piloti, spesso giovani e inesperti, nelle dinamiche di arrivo sul bersaglio e sgancio? Oppure hanno visto movimenti di civili e pensato a truppe militari? Oppure i piloti intimoriti dalla contraerea hanno sganciato a caso, per non tornare indietro carichi, con l’aereo appesantito e con la prova di non avere concluso la missione? Oppure, essendo vietato il ritorno col carico non sganciato, i piloti hanno scelto di rispettare le procedure e di liberarsi del carico in quella che credevano aperta campagna? Altre ipotesi si potrebbero fare, ma poco importa: sotto le bombe c’era una piccola frazione, Ca’ di Badin, oscurata di notte come era obbligo allora, ma esposta ed indifesa di giorno, ed una bomba, tra le molte sganciate nel territorio compreso tra Voze e Tosse, colpisce proprio una di queste case, all’estremità del borgo viario …
Come mai gli aerei alleati hanno sganciato nell’entroterra? Quale era il vero bersaglio? Qualcuno dice che erano missioni “diversive”, per distrarre il nemico, mentre si preparava uno sbarco altrove, o che il vero obiettivo era Spotorno, forse la ferrovia. Vero è che le azioni sui civili servivano a minare il morale della popolazione, ma le numerose bombe sganciate in quell’occasione erano praticamente in campagna, alle spalle dei centri rivieraschi. Quindi errore dei piloti, spesso giovani e inesperti, nelle dinamiche di arrivo sul bersaglio e sgancio? Oppure hanno visto movimenti di civili e pensato a truppe militari? Oppure i piloti intimoriti dalla contraerea hanno sganciato a caso, per non tornare indietro carichi, con l’aereo appesantito e con la prova di non avere concluso la missione? Oppure, essendo vietato il ritorno col carico non sganciato, i piloti hanno scelto di rispettare le procedure e di liberarsi del carico in quella che credevano aperta campagna? Altre ipotesi si potrebbero fare, ma poco importa: sotto le bombe c’era una piccola frazione, Ca’ di Badin, oscurata di notte come era obbligo allora, ma esposta ed indifesa di giorno, ed una bomba, tra le molte sganciate nel territorio compreso tra Voze e Tosse, colpisce proprio una di queste case, all’estremità del borgo viario …
La casa riunisce una famiglia del luogo, ma ironia del destino era piena di gente fuggita dai centri maggiori che riteneva di essere più al sicuro in un piccolo borgo di campagna. Il resto è riportato nelle memorie del parroco, raccolte in Archivio Storico Diocesano Savona, e recentemente pubblicate (insieme a molte altre) nel libro: “Memorie dei parroci della diocesi di Savona – Noli della Seconda guerra mondiale” (1940-1945) di Antonio Martino. Noi ne riportiamo un estratto.

Dal Diario personale di Don Quaglia …… segue… “nei pressi della Chiesa i Parrocchiani di Tosse scavarono nella viva pietra il loro “rifugio”. Da una quietanza in data 8 Maggio 1943 rilasciata dal Sacerdote Flavio Quaglia Parroco risultano versate L. quattrocento ottanta. Il foglio quietanzato porta l’intestazione “Istituto Nazionale Fascista per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro“. La somma su indicata rappresenta il versamento per rata di premio anticipato dall’8-V-43 al 30-VI-43.
Lì lavoro è fatto in parte a pagamento. I Parrocchiani non sono stati avari nel prestare anche la loro opera gratuita: 28 il giorno del bombardamento, verso le ore dieci, se ben ricordo, sempre del giorno 12 Agosto 1944 una grossa bomba veniva sganciata poco lontano dalla casa canonica nel terreno, penso, di proprietà di certo Frescia Domenico, che morì dopo qualche anno, avendo trascorso l’ultimo periodo della sua vita completamente cieco. Io ero fuori della casa canonica e senza avvedermene a seguito dello scoppio della bomba stessa mi trovai nelle “fasce” sottostanti la strada in direzione della finestra della vecchia cucina. Con me era un’altra persona che a distanza di tempo non riesco a ricordare la sua identità. dopo questa esplosione che io pensai di andare nel rifugio. Questo scavato nella roccia sulla strada che dalla casa canonica portava al centro-frazione e precisamente all’inizio di una stradicciola che dalla strada comunale porta alla casa di Frescia Giuseppe, era una galleria a ferro di cavallo. Poteva contenere in caso di emergenza forse anche una cinquantina di persone. L’immagine del Sacro Cuore era posta in alto visibile pertanto a molti. Era il segno della nostra protezione. Conservo tutt’oggi questa venerata immagine. Una contessa che abitava a Spotorno, sfollata in Tosse, aveva ornato questa immagine con fiori tessuti con fili di seta dai vari colori. Nel rifugio pertanto non ci sentivamo completamente soli.
 Quella mattina il rumore del passaggio degli apparecchi da bombardamento si era fatto più frequente. Si udì il rombo di esplosioni di bombe sganciate in territorio di Voze. Sul monte sovrastante il nostro rifugio. Finalmente la potente deflagrazione di quelle bombe che colpivano Cà di Badin e che mietevano un tanto grosso numero di vittime. Fattasi una certa calma nel senso che pur passando ancora di tanto in tanto qualche apparecchio, non aveva più luogo il bombardamento vero e proprio, si uscì dal rifugio. Il sole era letteralmente oscurato da una nube di polvere, fumo e terra che, salita in alto a seguito dello scoppio delle bombe, stava discendendo a terra lentamente, non solo sul posto da dove era stata sollevata, ma bensì anche a distanza di circa cento – centocinquanta metri in linea d’aria.
Quella mattina il rumore del passaggio degli apparecchi da bombardamento si era fatto più frequente. Si udì il rombo di esplosioni di bombe sganciate in territorio di Voze. Sul monte sovrastante il nostro rifugio. Finalmente la potente deflagrazione di quelle bombe che colpivano Cà di Badin e che mietevano un tanto grosso numero di vittime. Fattasi una certa calma nel senso che pur passando ancora di tanto in tanto qualche apparecchio, non aveva più luogo il bombardamento vero e proprio, si uscì dal rifugio. Il sole era letteralmente oscurato da una nube di polvere, fumo e terra che, salita in alto a seguito dello scoppio delle bombe, stava discendendo a terra lentamente, non solo sul posto da dove era stata sollevata, ma bensì anche a distanza di circa cento – centocinquanta metri in linea d’aria.
Ricordo che sui terrazzo della casa canonica se n’era depositata oltre un centimetro. Mentre esterrefatti si assiste a questo triste spettacolo, ecco giungere una persona dal luogo del disastro. Porta fra le braccia la piccola Carmen Ottonelli di anni quattro. L’infortunata ha la gamba sinistra fratturata. Il Parroco si accinge a portargli, come può e come sa, le cure del caso. Un’altra persona giunge ancora dal luogo del disastro e dà la ferale notizia certamente non attesa da alcuno, neppure lontanamente immaginata: A Cà di Badin ci sono dei morti. Fu allora che il Parroco preso l’Olio Santo si portò in quella contrada. Il sole era cocente. La sua forza aumentava data l’estate tanto secca, tanto asciutta. Va qui, tra parentesi, notato che le salme trasportate al Cimitero il giorno, mi sembra, quindici Agosto, giorno santo a Maria Assunta in cielo, dal grande calore, oltre al naturale fetore, emettevano un liquido che passando dalle fessure delle casse, preparate in fretta, perché così richiedevano le circostanze, dal caro e buono falegname di Tosse Arnello Sebastiano, venisse (questo stesso liquido) a contatto con le mani di coloro i quali caricavano e scaricavano dai carri le casse stesse. Non andò esente da questo contatto che potrebbe, sotto un certo punto di vista, chiamarsi sacro, chi scrive le presenti note. Volevo notare sopra, che quando l’immensa nube di fumo e di polvere per un istante aveva coperto come una coltre oscura la zona bombardata e si era estesa da Cà di Badin fin oltre la Chiesa, questa stessa massa di terra polverizzata resa oscura dal fumo emesso dalle bombe al momento dell’esplosione, era osservata anche dagli abitanti di Magnone e Voze.
Dal piazzale della Chiesa di Orco, mio fratello [Quaglia Giovanni Battista] parroco di quella Parrocchia, assieme ad alcuni suoi parrocchiani fissando questa nube oscura, che seguì il terribile fragore dell’esplosione delle bombe, cercava di individuare la località bombardata. In cuor suo pensava “Là è Tosse“. Il suo giovane e ardente cuore soffriva al pensiero che forse suo fratello, che scrive, avrebbe potuto subire danni alla persona dal bombardamento stesso. Un pensiero più triste lo colpiva e lo rattristava maggiormente, quello che il fratello avrebbe potuto anche essere stato vittima del bombardamento stesso. E’ proprio nei momenti di immani sciagure che l’amore fraterno dice tutta l’immensità della sua potenza. Penso gioia grande che provò il cuore di questo mio fratello quando ebbe certa la notizia della mia salvezza. Voglio qui dire una parola ancora a riguardo del caro bambino Somà Vittorio di dieci anni.
Mi sembra d’avere sentito io per il primo o certamente sentii assieme a coloro che con me salivano il mucchio di macerie, il suo lamento. Non lo si vedeva il povero bambino. Subito lo scoprimmo, lo portammo nella via che passa tra le vecchie case della contrada. Là io potei parlargli, suggerirgli una preghiera, dargli qualche mezzo cucchiaio di vino. I suoi occhi erano chiusi. Forse terribilmente colpiti da pietre o calcinacci? O solo impregnati di terra e polvere? In quel momento le sciagure erano talmente grandi che non attiravano più l’attenzione di chi circondava il caro bambino, i suoi begli occhi chiusi.
Si apriva invece la sua bocca, si staccavano le sue labbra per ricevere per metà il cucchiaio contenente vino offerto mi sembra dalla signora Ravera Luigia Magnone. Si faceva sentire la sua parola ben scandita sebbene fosse alquanto velata dal dolore grande che gli procurava la doppia frattura alle gambe. “Ancora da bere”. Come ricordo questa parola, o caro bambino. Io non solo ti avrei voluto fare quello che tu in quel momento chiedevi, calmare in te l’ardore della sete procurata a te dallo spavento, dalle ferite che hanno stroncato la parte inferiore delle tue gambe, ma ben molto di più io avrei voluto in quel momento fare, liberarti completamente dal tuo dolore. Vederti, magari col tempo guarito, essere per te, che eri rimasto solo, tuo padre, tua madre, tutti i tuoi fratelli, tenere cioè il posto della tua famiglia andata in un istante distrutta.
Come mai il piccolo Vittorio trovasi sul cumulo di macerie? Me lo sono chiesto più volte e non sono riuscito a darmi altra risposta. Certamente lo spostamento d’aria avvenuto al momento dell’esplosione delle bombe ha innalzato ad un altezza piuttosto grande il tenero fanciullo. Con lui sono saltate in aria, penso io, molte pietre, basti pensare che il legno principale che reggeva il lungo tetto andò in aria e tracciando poi un traiettoria nella discesa andò a conficcarsi nel tetto della casa della signora Garibaldi (di nome se ben ricordo) Maria, ora le pietre da me nominate nella discesa verso terra precedettero la caduta del corpo del piccolo Vittorio. Questi si trovò pertanto al disopra delle stesse.
Dove avvenne il bombardamento di Tosse del 12 agosto 1944 avvenne a Cà di’ Badin, contrada sottostante la Chiesa Parrocchiale di Tosse. Non si sa con precisione quante bombe abbiano colpito il luogo della sciagura. Risulta che molte di esse, esplose in zone terrose, sono esplose senza produrre grandissimi danni neppure alle colture. Queste che hanno procurato ben ventisette vittime sono cadute su di uno stabile di proprietà di certo Basadonne Vincenzo. La casa di questi scomparì completamente.
Penso che quella casa potesse misurare sette metri o anche più, per otto o dieci metri. Pertanto con una superficie di ottanta — cento metri quadrati. Era ad un solo piano, se ben ricordo, con i fondi. Dopo il bombardamento tutta la zona mutò faccia. Terrazzamenti scomparsi, muri a secco di vaste dimensioni completamente distrutti. Non si riusciva, di fronte a tanto mutamento, a ricostruire con la mente la realtà di prima. Perché fu bombardato proprio quel punto? Non è improbabile che dall’alto sia stato notato presso quella casa un certo movimento di persone. Però sta il fatto che bombe nella zona parallela alla Via Aurelia ne sono state sganciate un po’ ovunque.
Anche a Voze, nei terreni fra Voze e Tosse, così pure sempre alla stessa distanza dal mare ne sono state disseminate nei terreni sovrastanti a Spotorno e Bergeggi. Disgrazia volle che nell’abitazione del Basadonne Vincenzo ed in prossimità della stessa si trovassero tante persone. Va notato che poco lontano dalla casa di Basadonne Vincenzo, distrutta dal bombardamento, una donna si salvava col suo bambino rifugiandosi, poco prima dell’esplosione delle bombe, in una semplice “baracca” fatta di legno, e penso, dal racconto che mi hanno fatto della stessa, con le pareti chiuse da canne intrecciate. Distava questo luogo, da adibirsi a fienile, quattro o cinque metri dalla casa bombardata. Non ricordo chi fosse la mamma che teneva in quel momento fra le braccia una piccola sua creatura. Certamente una forestiera e facilmente di Spotorno.
La sistemazione delle salme- Le ventisette salme estratte dalle macerie furono tutte quante identificate, poste in una cassa costruita dal falegname Arnello Sebastiano di Tosse. Il 10 novembre 1944 il Parroco Sac. Flavio Quaglia avvicinava il Prefetto S.E. Mirabelli. Questi data la difficoltà del tempo governava la provincia dilaniata da lotte fratricide. C’era un governo che aveva una parvenza di legalità, nel senso che si era costituito quando il Re d’Italia abbandonò Roma alle sue sorti e fuggì vero il meridione. Presieduto da colui che per lunghi anni aveva dominato il popolo italiano, trovava difficoltà a reggersi perché vedeva incombere su se stesso una fine ormai prossima.
La potenza dei tedeschi cedeva di fronte a quella delle potenze alleate nemiche, con la caduta di questi doveva inesorabilmente cadere il governo che aveva fatto della cosiddetta Italia una Repubblica. Fu un tempo di transizione. L’opera degli alleati nemici delle truppe tedesche era appoggiato dall’opera dei Partigiani che i Repubblichini italiani chiamavano col titolo di Ribelli. Si dava pertanto questo triste fenomeno, che figli della stessa famiglia, Parrocchiani della stessa Parrocchia, cittadini della stessa città fosse politicamente e quindi militarmente non solo divisi, ma in posizioni completamente opposte tanto da dichiararsi nemici fra di loro.
Il Prefetto Mirabelli, o come si chiamavano in quel momento i Prefetti, il Capo della Provincia, come dissi, il 10 Novembre mi ricevette non nel palazzo della Provincia, ma in un villino, nella zona dove hanno la loro Casa i Padri Scolopi. Quell’uomo, primo Magistrato della Provincia di Savona, mi fece compassione. Era praticamente un recluso in quel villino. Guardie da lontano e da vicino lo sorvegliavano. Mi ricevette con molta affabilità. Mi ascoltò con attenzione e comprensione poi mi disse: “Fatemi avere un preventivo della spesa delle lapidi ricordo onde io possa concorrere nella stessa spesa”. Uscii da quell’udienza abbastanza soddisfatto. Non so poi praticamente quale fu il concorso della prefettura nella suddetta spesa. Da appunti che ho alla mano questa risulta di L. 10.600 (diecimila seicento) per lavoro di preparazione delle lapidi: ciò presso
la ditta del marmista Michele Pellegrini. Risulta altra spesa di L. 9,000 (novemila) incontrata presso altra ditta Borgna. Furono poi spese 1.400 (millequattrocento) per la posa in opera delle stesse lapidi e la sistemazione del campo. Da una lettera da me inviata al Commissario Prefettizio di Noli risulta che quel Comune ha elargito a titolo di contributo per le spese delle lapidi come sopra detto la somma si L. 3.000 (tremila). La lettera, che ha lo scopo di ringraziare il detto Commissario è stata allo stesso inviata nel mese di gennaio 1945. Il Parroco di Tosse curava l’incasso di detta somma presso la tesoreria comunale di Noli il 19 gennaio 1945. Le lapidi in marmo bianco misuravano metri 0,65 x 0,35. Nella parete del muro di cinta del cimitero (soprastante le lapidi) fu posta una targa in marmo bianco con epigrafe” … segue…
Sacerdote Flavio Quaglia– Ci sono molte tipologie di bombardamento aereo. Le più usate sono i bombardamenti a tappeto e quelli puntiformi. I primi prevedono di coprire un obiettivo di notevoli quantità di bombe, facendo “tabula rasa”, i secondi invece prevedono poche bombe lanciate con precisione su un bersaglio. Secondo wikipedia i bombardamenti si dividono in:
- il bombardamento tattico ha come scopo la vittoria immediata in battaglia – per esempio durante la prima guerra mondiale le trincee nemiche erano fatte oggetto di un intenso cannoneggiamento prima dell’assalto delle fanterie;
- il bombardamento strategico, teorizzato nell’intervallo fra le due guerre mondiali da studiosi fra i quali l’italiano Giulio Douhet ed applicata nel corso della seconda guerra mondiale, ha come obiettivo la vittoria dell’intero conflitto; nel bombardamento strategico i bersagli non sono necessariamente di tipo militare, per esempio durante la seconda guerra mondiale i bombardamenti strategici hanno diffusamente colpito città e abitanti (Londra, l’Italia o la Germania ed il Giappone a fine conflitto) allo scopo sia di ridurre le capacità produttive del nemico sia di fiaccare la resistenza e deprimere il morale della popolazione;
- il bombardamento operativo, a metà strada tra i due precedenti, ha come obiettivo la riuscita di un’operazione militare, e colpisce obiettivi che non siano classificabili né come propriamente tattici, né come propriamente strategici; per esempio durante lo sbarco in Normandia le forze aeree angloamericane furono utilizzate sia in un senso tattico, ovvero come appoggio, colpendo i bunker tedeschi sulla costa, al fine di facilitare le operazioni di sbarco, sia in senso operativo, colpendo le immediate retrovie del Vallo, per favorire il consolidamento della testa di ponte e preparare la possibilità di aprire un varco per una successiva avanzata via terra.
Giuseppe Testa