Ci sono ottime probabilità che l’estate 2025 si ponga al vertice delle classifiche degli anni più caldi in assoluto, come accade ormai un anno dopo l’altro.
di Tiziano Franzi
A giugno e nella prima decade di luglio le temperature sono schizzate verso l’altro ovunque, non solo in Italia. La temperatura globale media dell’aria in superficie è stata 15,79°C, vale a dire 0,53°C in più rispetto alla media del periodo 1991-2020 e quasi un grado e mezzo sopra la media del periodo 1850-1900, indicata come riferimento per il periodo pre-industriale.
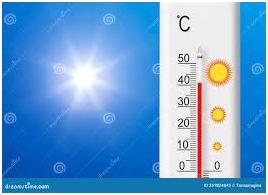
Ma è preferibile un’estate torrida o l’assenza totale dell’estate?
Sembra una domanda assurda. Invece è riferita a quanto accadde 164 anni fa.
Il 1816 è infatti famoso in Italia e nel mondo come “l’anno senza estate” a causa delle condizioni climatiche estreme e anomale che hanno portato a un abbassamento delle temperature globali. Questo fenomeno fu principalmente causato dall’eruzione del Monte Tambora in Indonesia nel 1815, una delle più potenti della storia, che disperse nell’atmosfera una grande quantità di polveri e ceneri, bloccando la luce solare.
L’eruzione del Tambora del 1815 fu l’eruzione vulcanica più potente mai registrata in epoca storica, con VEI pari a 7. Tra 4 000 e 4 300 m s.l.m. Il monte Tambora si trova sull’isola di Sumbawa nell’odierna Indonesia, allora facente parte delle Indie orientali olandesi; l’eruzione durò quasi due anni, dall’aprile 1813 al giugno 1816. L’esplosione del vulcano ebbe caratteristiche mai più registrate, quali : flussi piroclastici, tsunami, terremoti, scoppio della caldera, caligine dovuta alla concentrazioni di polveri pari a 100-175 miliardi di metri cubi

In Italia, come in altre parti d’Europa, si verificò un’estate eccezionalmente fredda e piovosa, con nevicate anche a giugno, che causarono carestie e difficoltà economiche.
L’evento del 1816 è ricordato non solo per il suo impatto climatico, ma anche per le conseguenze sociali ed economiche che ebbe, e come monito sui rischi legati ai cambiamenti climatici.
Ecco alcuni dettagli specifici per l’Italia: temperature molto basse e abbondanti piogge, con nevicate anche a giugno; scarsità di cibo causata dal maltempo che portò a una grave carestia in molte regioni italiane; la mancanza di grano e altri prodotti alimentari fece esplodere la rabbia della popolazione, già provata dalle guerre napoleoniche; tumulti e i saccheggi furono comuni, e molte persone cercarono di emigrare in cerca di cibo e migliori condizioni di vita.
Ma è il 536 l’attuale candidato per essere considerato l’anno peggiore della storia dell’umanità. Sembra che la causa scatenante sia stata ancora una volta un’eruzione vulcanica, o forse più di una, da qualche parte nell’emisfero settentrionale.
Ovunque fosse, l’eruzione ha scatenato un “inverno vulcanico” della durata di un decennio, durante il quale la Cina ha subito nevicate estive e le temperature medie in Europa sono scese di 2,5°C. Le colture non sono cresciute. La gente ha sofferto la fame. E si sono armati gli uni contro gli altri.
Nel 541 poi la peste bubbonica arrivò dall’Egitto e riuscì a uccidere un terzo della popolazione dell’impero bizantino.
Anche nel lontano Perù, la siccità colpì la fino ad allora fiorente cultura Moche.
L’aumento dello strato di ghiaccio dell’oceano (un effetto di retroazione del vulcanico inverno) e un intenso minimo solare (il periodo regolare che presenta la minore attività nel ciclo solare di 11 anni del Sole) nell’anno 600 assicurarono che il raffreddamento globale continuasse per più di un secolo.
Molte delle società che vivevano nel 530 semplicemente non sono riuscite a sopravvivere alle devastazioni che si sono scatenate nei decenni successivi.
Il cambiamento climatico, insomma, non è solo un aspetto della società moderna.
Ma quelli citati furono episodi isolati, seppure macroscopici e di lunga durata. Ciò che preoccupa maggiormente gli scienziati, oggi, è la continuità nel tempo e nello spazio terrestre di eventi climatici al di fuori di ogni “regola” stagionale, con elevate temperature del suolo terrestre e della superficie marina fino a 5 metri di profondità, con l’improvviso scontro di masse aeree fredde , che provoca devastanti e incontrollabili inondazioni e conseguenti devastazioni di portata mai registrata in passato.
Tiziano Franzi




