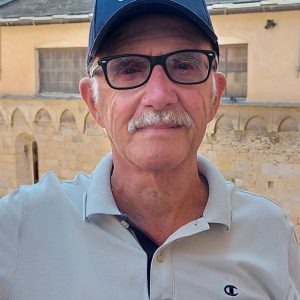L’Archivio di Stato che compie 87 anni, pubblico e gratuito, che dovrebbe essere il fiore all’occhiello di ogni comunità, rischia il tracollo per la mancanza di personale e fondi. Savona ha enormi risorse che quasi nessuno conosce.
di Gianfranco Barcella

In Corso Ricci c’è la casa di Leon Pancaldo, uno dei pochissimi sopravvissuti al viaggio di Magellano che per primo circumnavigò il mondo. In via Valcada c’è una delle case comprate dalla famiglia di Cristoforo Colombo ma non sono in molti a saperlo. A Savona è passata la Storia lasciando tracce ovunque. Due papi savonesi e un altro che a Savona è stato imprigionato da un certo Napoleone.
Maurizio Biagini, savonese, laureato in Lingue e Letterature Straniere Moderne all’Università di Genova. Docente di Inglese al liceo artistico “Arturo Martini” di Savona, esordisce nella narrativa nel 2009 con Tempo determinato. Una raccolta di racconti che ha vinto numerosi premi e segnalata alla XXIIa edizioni del Premio Italo Calvino.
Nel 2012. Biagini pubblica Rock and Roll, un romanzo di ribellione e passione sulla cultura musicale per eccellenza. Nel 2013, con Condominio Italia, vince il premio: “Il racconto nel cassetto”.
Nel 2020 esce il romanzo Sulla linea di fondo per Edizioni La Gru, in cui racconta la storia di una comunità colpita dalla crisi di una fabbrica e dalla malattia causate dall’inquinamento industriale. Tutto è raccontato attraverso la vita di un giovane calciatore e della sua famiglia, colpita dalla crisi sociale e economica. La frustrazione e la rabbia della comunità finiranno per sfogarsi sulla squadra di calcio in cui gioca il protagonista, attraverso la cornice narrativa di un campionato di calcio.
Ha studiato a fondo la Prima guerra mondiale all’Università e in seguito ha approfondito la sua conoscenza degli eventi bellici anche attraverso saggi di autori inglesi e americani inediti in italiano, e un’approfondita analisi sul campo.
Lei e Massimo Macciò avete proposto di recente un evento riguardante la Grande Guerra. Come è nato il suo interesse e come si è sviluppato il progetto?
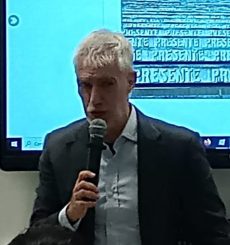
Ho studiato a lungo gli eventi della Grande Guerra ma la scintilla è arrivata a scuola. Insegnando inglese, mi trovo a trattare anche la storia della Gran Bretagna, oltre che alla lingua e alla letteratura. In Gran Bretagna viene celebrato il Remembrance Day, ogni primo luglio (battaglia delle Somme) e parte importante del programma di quinta riguarda i War Poets, i soldati che scrissero dell’evento attraverso la poesia. In quinta bisogna collegare gli eventi con il programma di storia e letteratura del nostro paese, e allora ho condiviso quello che sapevo anche sul fronte italiano evidenziando gli aspetti paradossali sotto il profilo economico e sociale. Ne è nata una sorta di narrazione teatrale, un percorso sulla follia umana e delle sue vittime di quegli anni.
Un giorno ho scoperto che Massimo Macciò faceva delle conferenze sulle cause reali che portarono allo scoppio del conflitto, argomento non trattato sui libri di scuola che si limitano a un’analisi politica piuttosto superficiale. Lo so: può apparire strano ma si riesce anche a ridere per non piangere. C’è da fare ancora molta satira sul potere e sulla follia umana che a volte lo sostiene anche nelle sue espressioni più aberranti e disumane. In seguito, insieme a Massimo Macciò abbiamo deciso di mettere insieme due narrazioni. Così è nato “Un gioco finito male”. L’idea è raccontare i fatti liberandoli dalla retorica e dalla censura che esiste ancora adesso: raccontando gli eventi paradossali dal punto di vista militare e sociale ci si trova a ridere del potere e della stupidità umana. Massimo Macciò espone la parte iniziale, che tratta delle reali ragioni economiche del conflitto. Io passo a raccontare la vera Italia all’inizio del conflitto, con tutte le sue contraddizioni. Poi c’è la parte dell’assurdo, l’evoluzione della tecnologia che contrastava sempre più vistosamente con la mentalità ottocentesca e che finì per confluire in un massacro. Utilizzando la satira abbiamo raccontato il ridicolo di eventi di per sé assolutamente tragici come La Somme, Verdun e Caporetto, in cui l’assurdità degli stati maggiori ha macellato i loro stessi eserciti.
Un gioco finito male ha questo senso: gli interessi economici, una guerra sfuggita a ogni logica se non all’interesse disumano del capitalismo, e il rispetto dovuto ai ragazzi mandati al macello. Il progresso industriale ha finito per rivoltarsi alla stessa natura umana.
La prima dell’evento è stata proposta agli allievi del Liceo Artistico “Arturo Martini”, poi abbiamo replicato all’Archivio di Stato. Nella seconda occasione, è stato proposta all’attenzione degli spettatori anche materiale d’archivio grande interesse come i fogli matricolari di Sandro Pertini e Cristoforo Astengo, entrambi reduci della Grande Guerra. Tra febbraio e marzo riproporremo questa rappresentazione sulla Prima Guerra Mondiale con qualche novità: l’Archivio di Stato mostrerà documenti inediti del periodo ed io stesso porterò oggetti del conflitto, collezionati nel tempo. Questa volta l’evento sarà aperto a tutti e si dividerà tra la nostra conferenza e la visione del materiale documentale proposto dall’Archivio.
Come affrontano questi temi gli studenti?
Con grande interesse. È quello che cerchiamo di fare: creare interesse. Per questo mostriamo foto, oggetti e documenti. Ci sono momenti drammatici e altri in cui si ride. La Grande Guerra, in fondo, è sempre stato un paradosso. A pensarci bene, l’unico film importante mai girato sull’evento è stato il film di Monicelli, una commedia con punte drammatiche in cui i due ridicoli protagonisti finiscono per diventare degli eroi dimenticati. Per il resto, tutto quello che è stato girato sulla Grande Guerra in Italia è roba di serie B. Ovviamente ci sono le due versioni cinematografiche di Addio alle armi, scritto da Hemingway che fu sul fronte italiano e raccontò nel suo romanzo la barbarie del conflitto, il sacrificio dei soldati italiani e la violenza assurda delle decimazioni (e il romanzo venne fatto sparire durante il Ventennio). Se leggete Emilio Lussu, Un anno sull’altopiano, vi rendete conto dell’ironia che traspare nella tragedia.
La Grande Guerra ha tutti i mali che hanno sempre afflitto il nostro Paese: la corruzione, la superficialità, la mancanza di responsabilità del Potere e lo scaricabarile. Io dico sempre che a poca distanza di Caporetto c’è la diga del Vajont: le ragioni dei disastri sono le stesse. I ragazzi imparano quanto sono fortunati a non dover vivere quello che passarono i loro avi. Usiamo molti paragoni con il loro vissuto, per esempio che nelle trincee esistevano i social, cioè i pidocchi: i soldati si spidocchiavano tra di loro. E magari, spidocchiandosi, si raccontavano e superavano le barriere sociali e culturali.
Poi c’era la posta. I nostri avi hanno scritto miliardi di lettere, e al 50% erano analfabeti che si arrangiavano. C’era forte necessità di raccontarsi, la stessa, in fondo, che hanno oggi i ragazzi.
L’obiettivo, alla fine è far capire agli studenti e, speriamo, al pubblico che quello che è successo ieri potrebbe succedere anche a loro in un futuro ormai non più troppo distante, e che la guerra non è la Playstation, ma è sporca di fango, sangue, fame e malattie.
Quale valutazione complessiva dà sulla scuola savonese?
Ogni scuola ha una realtà propria, le proprie problematiche e le proprie soluzioni. Inutile soffermarsi sul territorio, dovremmo guardare alla scuola nella sua situazione nazionale. I fondi di scuola e sanità vengono tagliati da decenni ed entrambi i settori hanno un enorme contributo di volontariato che è una delle forze che reggono questo paese e che molti danno per scontato.
La domanda è: come mai in Italia paghiamo enormi cifre in tasse e i servizi pubblici hanno personale ridotto, anziano e strutture non all’altezza? Ognuno si dia le sue risposte.
Nel Savonese vedo comunque un grande sforzo didattico per ovviare ai problemi dei giovani, che sono sociali, economici e culturali, come d’altra parte è sempre stato. Tutti danno per scontato il nostro lavoro, però, senza pensare che su di noi passano tutte le problematiche del paese. I ragazzi portano il loro vissuto quotidiano a scuola. Il disagio giovanile ha anche radici economiche e sociali che non riguardano solo il problema di crescere.
Da uomo di cultura e impegnato nel campo educativo quali suggerimenti offre al sindaco per valorizzare il progetto di Savona, città candidata a Capitale italiana della cultura nel 2027?
Abbiamo enormi risorse che quasi nessuno conosce: a Savona è passata la Storia lasciando tracce ovunque. Due papi savonesi e un altro che a Savona è stato imprigionato da un certo Napoleone. Per fare un altro esempio, in Corso Ricci c’è la casa di Leon Pancaldo, uno dei pochissimi sopravvissuti al viaggio di Magellano che per primo circumnavigò il mondo ed in via Valcada c’è una delle case comprate dalla famiglia di Cristoforo Colombo ma non sono in molti a saperlo.
Molto testimonianze della storia di Savona sono conservate in quel gioiello di storia e di cultura che è l’Archivio di Stato di Savona, che proprio nel 2027 compirà ben 85 anni e che merita di essere ulteriormente conosciuto e valorizzato. È anche per questo che teniamo eventi nella sede leginese, bellissima e misconosciuta di Valletta San Cristoforo, ultimo “approdo” per un’istituzione che ha letteralmente girato la Città, spostandosi in diverse sedi con il suo prezioso patrimonio al seguito. È incredibile la quantità e la qualità del materiale custodito lì dentro: quasi mille anni di storia, dal Medioevo alla seconda guerra mondiale e oltre. C’è roba dal valore incalcolabile, consultabile da chiunque. Ma un istituto pubblico e gratuito, che dovrebbe essere il fiore all’occhiello di ogni comunità, oggi rischia seriamente il tracollo per la mancanza di personale e fondi: ci sono luoghi che sono la Storia e l’Arte, ma i turisti delle navi da crociera vengono portati altrove.
Ricordo che il Mare è già cultura. Possibile che nessuno crei qualcosa sulla storia della navigazione della nostra città? Non è facile, ma con un piccolo sforzo d’immaginazione valendosi della competenza del personale si possono creare anche musei e mostre, non solo centri commerciali. Insomma: se riuscissimo a cogliere l’occasione per creare e diffondere cultura? Tra l’altro (e in Italia abbiamo qualche esempio notevole) la cultura, se ben gestita, muove anche l’economia.
Quali sono i progetti editoriali per il futuro?
Dovrebbe uscire il quarto libro. Narrativa: una raccolta di racconti che parla di quest’epoca in cui tutto sta per finire ma che in realtà porterà a cambiamenti che, ovviamente, fanno paura. La Storia è tutta qua, cambiamento e resistenza al cambiamento. Dall’opposizione al cambiamento arrivano colpi di stato, guerre civili, dittature… la verità e che il cambiamento è inevitabile. Puoi rimandarlo, ma alla fine arriva lo stesso. Il congresso di Vienna ha provato a portare indietro l’Europa dell’Ottocento, ma alla fine la fame di giustizia e democrazia ha prevalso. Il mio libro parla di storie di persone comuni di fronte a situazioni come colpi di stato, guerre ma anche la censura e il pregiudizio contro le donne e i giovani. Alla fine di ogni storia ti rendi conto che ci sarà un nuovo inizio.
Se ci si pensa, noi “analogici” ci siamo trovati di fronte a un cambiamento incredibile. Abbiamo dovuto cambiare il nostro cervello e adattarci a Internet, pagamenti elettronici, cellulari. Ne abbiamo avuto paura e disagio, molti rimpiangono il passato ma ci potevamo fare qualcosa? Il digitale e Internet sono inarrestabili. Puoi brontolare e andare a vivere in una grotta, ma il mondo non lo puoi cambiare.
Rispetto a Linea di fondo, c’è una grande differenza di approccio. Il romanzo era articolato con storie che si intersecavano; per Storie alla fine ho deciso per i racconti, così da poter spaziare in momenti e luoghi diversi. In realtà è tutto meno che un libro triste. Credo che il lettore si sentirà meno solo e più parte di un mondo in cui il singolo può fare la differenza.
Gianfranco Barcella