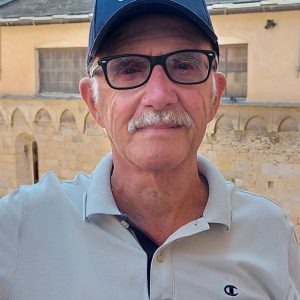Badalucco- LA CAVERNA BERTRAN- ( Prima parte).
di Tiziano Franzi

Nascosta tra le montagne di Badalucco, la grotta situata in località Bertran e studiata sin dall’Ottocento per le specie di insetti che vivono al suo interno, divenne un sito archeologico grazie alla casuale scoperta dell’entomologa inglese Grace Mary Crowfoot. La studiosa, con grande difficoltà logistiche, era riuscita a identificare la caverna (o “grotta”, o “tana”) Bertran (citata anche dalla stessa Crowfoot come “Bertrand“) per compiere una ricerca sugli scarafaggi ciechi che, secondo le sue informazioni, erano presenti nell’anfratto.
Così scrive la Crowfood:«Tutto ha avuto inizio nell’inverno del 1906, durante il mio soggiorno a Sanremo. Avevo già sentito parlare della grotta Bertrand, sono stati soprattutto gli amici naturalisti a raccontarmi cosa si nascondeva al suo interno. La grotta era famosa per la presenza degli scarafaggi ciechi, scoperti da due entomologi, Dodero e Spagnolo. Ancora non sapevo che altri “abitanti” attendevano di essere scoperti, Così, insieme agli amici del Circolo culturale di Sanremo, sono partita in cerca della grotta e degli scarafaggi ciechi. Il viaggio è stato lungo da Sanremo a Badalucco abbiamo viaggiato in omnibus per circa due ore – gli omnibus erano il trasporto pubblico dell’epoca, una carrozza capiente trainata da cavalli veri, ma credo che non esistano più. Da Badalucco siamo ripartiti a piedi e, dopo un’ora e mezza di cammino nel bosco, finalmente siamo arrivati alla grotta Bertrand. Nascosto tra alberi e arbusti, l’ingresso era molto stretto e obliquo, ricordava vagamente un triangolo storto. Per entrare in quel collo di bottiglia ci siamo abbassati di molto, quasi strisciavamo, ma anche dove la grotta diventava più larga non siamo riusciti ad alzarci in piedi. Non pensate di trovare meraviglie della natura, sembrava piuttosto una grotta di fantasmi. Mentre guardavo le pareti in cerca degli scarafaggi ciechi, assolutamente per caso, mi sono imbattuta in qualcosa di inaspettato: proprio sopra il basamento della grotta, ho visto due mascelle e un osso lungo e stretto, forse un omero. Erano resti umani, non c’erano dubbi, ma di chi e di quando?»
Ha avuto così inizio, casualmente come spesso avviene in questi casi, una delle scoperte più importanti dell’archeologia preistorica ligure. Continua infatti la studiosa:«Nessuno di noi era in grado di rispondere a queste domande in maniera precisa. Tornata a Sanremo, ho scritto ad alcuni specialisti, Henry Ogg Forbes, Arturo Issel ed Émile Cartailhac. Tutti concordavano nell’affermare che i resti umani risalivano all’età del Rame, a circa 2800-1800 anni prima di Cristo. Da quel momento il detto “Vecchio come la tana Bertrand” è diventato il mio preferito.»
Grace Mary Crowfoot procedette a scavi superficiali e limitati nello spazio di quella caverna che era così angusta da renderne difficile il transito interno, per una decina di centimetri in superficie e pochi metri in lunghezza, ricavandone comunque resti significativi. Le analisi a cui quei resti furono sottoposti in Inghilterra confermarono infatti che si trattava di resti umani risalenti all’età del Rame non lasciavano dubbi sul suo utilizzo: la tana, sul fianco occidentale del Monte Faudo, a 800 metri s.l.m., è una grotta sepolcrale. L’unica grotta in tutta la Liguria che in epoca preistorica fu adibita esclusivamente a sepolcreto”.
Molte sono infatti le grotte o caverne nel Finalese -e non solo- in cui coloro che le abitarono durante la Preistoria adibivano una parte di essa alla sepoltura dei cadaveri di coloro che erano appartenuti al clan, soprattutto se si trattava di individui che avevano ricoperto un ruolo sociale importante: basti pensare alla sepoltura del cosiddetto “Principe delle Arene Candide”.
Ma in questo caso il sito non era stato abitato, bensì utilizzato esclusivamente come luogo di sepoltura, il che ne faceva un luogo esclusivo di grande interesse storico e antropologico.
«Pubblicai – prosegue laCrowfoot– il resoconto delle mie scoperte nell’articolo “Note sugli scavi in una grotta ligure“, apparso sulla rivista «Man»nel 1926: erano passati esattamente 20 anni dai primi scavi. Perché così tanto, direte voi. Avrei voluto tornare a Badalucco, compiere altri scavi e pubblicare un articolo più completo, ma la vita mi portava sempre più lontano dalla Liguria. Scelsi quindi di scrivere il resoconto, magari parziale, consapevole del fatto che molto altro sarebbe stato scoperto dai miei colleghi archeologi. Se avrete modo di leggerlo, troverete il disegno della grotta fatto da me. Potete immaginare quanto sia stretta e buia?»
Nell’articolo apparso sulla rivista «Man», Grace Crowfoot descrive quanto ritrovato nella tana Bertran tra il 1906 e il 1909: punte di freccia in selce, un ago ricurvo e pendenti in osso, gusci a chiocciola, resti animali, ossa umane, in particolare omeri e frammenti di cranio riferibili a circa 10 individui, circa 300 perline in ematite e steatite di forme diverse. Alcune di queste formano collane particolari perché caratterizzate da un’alternanza di perline semplici e perline con una protuberanza, le cosiddette pietre lavorate ad alette, un ornamento rappresentativo dell’età del Rame, tipico della Francia e per la prima volta scoperto in Italia. Questo ci suggerisce la possibilità di scambi e relazioni tra le popolazioni della Valle Argentina e quelle del sud della Francia.
Ancora Mary Crowfood scrive: «Quando ritrovai i resti umani nella tana Bertrand, l’istituzione museale di riferimento nell’imperiese era il museo Bicknell di Bordighera. Fu quasi spontaneo, quindi, donare a questo museo le ossa umane che giacevano nella tana.»
Sin dalla loro scoperta, i reperti della tana Bertran subiscono una dispersione. In mancanza di una legge che tuteli il patrimonio nazionale, molti reperti vengono portati in Inghilterra dalla stessa Crowfoot: si tratta di due collane di perle in steatite e in osso, alcuni pendenti e punte in osso. Rimasti per qualche decennio alla famiglia, dopo la morte di Molly vengono donati all’Ashmolean Museum di Oxford, dove lavora Joan, la secondogenita dei Crowfoot. Attualmente sono ancora conservati presso questo museo.
Dal resoconto di Mary Crowfoot sappiamo che i resti umani trovati durante i suoi scavi vengono donati da lei stessa al museo Bicknell di Bordighera, cui si aggiunge la donazione di una collanina di perle ad alette fatta da Molly nel 1948. Successivamente, il museo Bicknell dà in comodato d’uso l’intera collezione al museo civico di Sanremo, gestito dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri, dove è esposta ancora oggi. Altre perline semplici e ad alette provenienti dagli scavi fanno parte delle collezioni dell’Università di Genova, mentre la più importante collana di perle ad alette è conservata al museo Pigorini di Roma, acquistata nel 1935 dal neodirettore Pietro Barocelli.
Dopo avere vissuto con la famiglia a lungo in Africa continuando i propri studi, la Crowfoot muore in Inghilterra nel 1957. Con la sua scomparsa sembrava che il destino della grotta Bertran avesse trovato la propria fine. Ma non fu così, fortunatamente, come vedremo in un prossimo articolo.


Tiziano Franzi